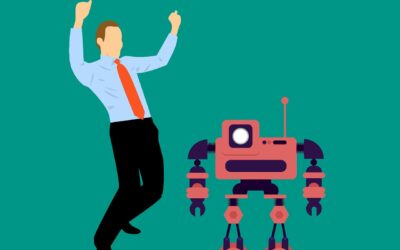Come e perché festeggiare il 25 aprile? Lo storico dovrebbe fare osservare come, già nella data scelta per la celebrazione liturgica della Liberazione, si annidi una problematicità. In linea generale, la questione potrebbe essere la seguente: che cos’è la scansione con cui organizziamo il tempo storico (inizio, durata, fine) se non il frutto di una scelta, una visione? La storia diventa immediatamente storiografia e quando c’immaginavamo di aver a che fare con una “scienza”, ci troviamo tra le mani un racconto da codificare: da cui la necessità di essere attenti filologi del nostro tempo.
Quando poi l’analisi si volge sul piano della scelta delle date con cui celebrare ufficialmente la vita e lo sviluppo di un Paese, si capisce come ci si situi, immediatamente, sul piano scivoloso della public history. Insomma, bisogna indagare a fondo. Intanto, si dica che la liberazione effettiva ebbe luogo tre giorni dopo, ma il problema è che il 28 aprile si fucilarono Duce e parecchi gerarchi, e il giorno del redde rationem con il fascismo non pareva proprio l’ideale per celebrare, all’alba della repubblica italiana, l’inizio dei lavori di rieducazione alla libertà e alla democrazia. Bisognava defascistizzare gli Italiani e per farlo occorrevano moderazione e saggezza. Così si retrodatò la Liberazione per non ferire gli ancora assidui simpatizzanti del Duce.
D’altronde, la stessa scelta del significante “Resistenza” per racchiudere il senso complessivo delle vicende italiane tra l’8 settembre e la Liberazione, non fu per nulla frutto spontaneamente traboccato dalle labbra degli antifascisti: il lemma nacque in laboratorio post rem. Come ha fatto notare Adriano Ballone – in un suo saggio pubblicato nel volume I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita – “Resistenza” era un’allusione, una metafora e, come tutte le allusioni e le metafore, causa di non pochi problemi ermeneutici.
Intanto, il termine era riduttivo, poiché limitava il significato storico e politico di un movimento armato di volontari/partigiani/patrioti ribellatisi allo Stato fascista e all’occupante nazista, ad atteggiamento di difesa: ma difesa di che? Di quale patria? Anche i fascisti rivendicavano una patria ed era quella che aveva deciso di non tradire l’alleato nazista. Inoltre, la patria italiana era incarnata dal re? Quello che era fuggito da Roma e aveva trovato riparo presso gli ex nemici americani? “Resistenza”, poi, aveva un altro difetto: era ridondante poiché esasperava il carattere unitario, popolare, nazionale del riscatto italiano e democratico, quando in realtà si trattò in primis di guerra civile («fratricida» sarebbe troppo, ma anche questo si disse).
Già dal 1946, inoltre, si affiancò al termine “Resistenza” quello di “Secondo Risorgimento”. Era fatto proprio da chi ovviamente propendeva più per il racconto di una “Resistenza tricolore” che di una “rossa”. Vi erano elementi di verità storica perché il movimento partigiano e patriottico di ribellione al nazifascismo effettivamente rappresentò, in un certo senso, una sorta di compimento del Risorgimento come movimento popolare. Una rivendicazione dal basso iniziata dapprima con i moti organizzati dalle élite liberali dell’aristocrazia militare (un’élite fortemente debitrice tanto dell’impianto ideologico rivoluzionario francese quanto dell’esperienza militare napoleonica), poi sviluppatasi con la Primavera dei Popoli, i primi esperimenti repubblicani (la Repubblica romana) e i tentativi insurrezionali mazziniani.
Va qui certamente relativizzata la nozione di “popolo”: chi insorge sono i ceti medi, qualche aristocratico, intellettuali infervorati dal verbo romantico-mazziniano, e le plebi urbane: è questo il popolo ottocentesco, l’unico “popolo” immaginabile, in effetti, se consideriamo la siderale distanza da cui osservavano, stupefatti e diffidenti, le plebi rurali. È “popolo” una comunità di persone che si riconosce in un complesso mitologico, in una leggenda, una bandiera, una dimensione un po’ più ampia della propria famiglia o clan di appartenenza. I contadini non erano “popolo”.
Il “completamento” apportato dalla Resistenza consisteva proprio in questo: nell’aver consentito a fasce più estese di popolazione e in primis ai contadini di prender parte alla storia nazionale e a un possibile progetto emancipativo. D’altronde, la prova della continuità simbolica tra Risorgimento e Resistenza è data da tutto il complesso iconografico, immaginario, letterario, artistico, che lega insieme i moti per la liberazione e l’indipendenza nazionali a gran parte dei codici estetici, politici e morali dell’antifascismo: si pensi soltanto alla straordinaria continuità della fortuna del mito garibaldino presso i partiti di sinistra e il movimento operaio.
Infine, il nesso Risorgimento-Resistenza è qualcosa di più di un mero espediente narrativo: o, forse, la forza trainante del suo racconto è in ragione di una solida analogia strutturale: tanto la storia degli eventi politico-militari quanto il loro storytelling hanno davanti a sé un nemico in carne e ossa: lo straniero, presentato, anche a ragione, come «barbaro e vile», spietato e terribile. Fu in questo modo che si poté costruire una comune epica popolare, che presentava peraltro uno straordinario merito organizzativo: consentiva di unire narrativamente forze umane e politiche altrimenti divise: perché a caratterizzare tanto il momento risorgimentale quanto resistenziale fu più la divisione che l’unione. Inevitabile che anche la memoria della “Resistenza” finisse per uscirne scissa, racconto dimezzato, mai realmente condiviso dal corpo della nazione.
Una nazione repubblicana divisa, dunque, e proprio sul suo evento fondativo. Lo scontro tra le narrazioni prese le mosse con la rottura politica andata in scena tra le forze del CLN e che prese vieppiù alimento dal clima politico repressivo degli anni cinquanta, in cui, cioè, era sempre più netta la contraddizione tra la lettera della Costituzione e lo spirito anticomunista della sua traduzione politica. Mentre nelle commemorazioni degli anni Cinquanta, il “problema Resistenza” sembrò quasi scomparire dall’agenda delle celebrazioni ufficiali, dai programmi scolastici e dalle università, grazie ai fatti del luglio 1960 (con la scesa in piazza di una protesta generazionale e politica di inaudita violenza) e all’approdo al governo del centrosinistra, l’antifascismo entrò a pieno titolo nel calendario della Repubblica e, così, fecero la Resistenza e la Costituzione, che vennero celebrate ufficialmente nel corpo liturgico della ritualità nazionale, furono accolte nei manuali scolastici e salutate con entusiasmo dagli studenti universitari.
Si consolidò anche il paradigma resistenziale della sinistra che, dalle colonne de «L’Unità», lo collocava stabilmente come criterio interpretativo degli scenari di lotta anticoloniale e antimperialista (a Cuba, in Algeria, nel Congo e in Vietnam), come ricorda opportunamente Gianpasquale Santomassimo [1].
Parallelamente, s’ingrossava la retorica fiume del discorso istituzionale, che era poi tra le cause principali di nausea e indifferenti alzate di spalle dei giovani. La Repubblica italiana guardava ancora al popolo idealizzato dal paradigma resistenziale del Secondo Risorgimento, ma ora esso era separato dalle sue radici storiche e politiche: la parabola resistenziale era ormai al di là del registro discorsivo ottocentesco e confluiva in un non ben precisato avanzamento democratico e sociale. Il socialismo sui generis e il repubblicanesimo mazziniano, il cui appello al popolo conteneva elementi poco assimilabili al contesto moderato del liberalsocialismo di governo – si ricordi, en passant, che tanto il socialismo etico-religioso di Mazzini quanto il garibaldinismo avevano ben poco a che spartire con il modello di rappresentanza liberaldemocratica dell’età contemporanea ma piuttosto con la democrazia radicale dei giacobini [2] – erano al più derubricati come esotici e in fondo romantici appelli a un mondo che non c’era più e che era giusto ritornasse a essere ospitato nei polverosi libri di storia e teoria politica.
Da questo punto di vista, nonostante la sua verbosità rivoluzionaria, anche il Pci accreditò la visione lineare ed evolutiva di una progressiva e acritica integrazione dell’elemento popolar/proletario all’interno delle istituzioni dello Stato repubblicano. Una normalizzazione che non solo tradiva le istanze di giustizia sociale della Resistenza ma anche quelle di Mazzini che, peraltro, risultava tradito al quadrato, dopo aver assistito, ancora in vita, al trionfo cavouriano e all’annessione piemontese delle regioni italiane (detta anche Unità).
Fu con gli anni settanta che, in virtù dell’insanabile frattura tra il racconto della Resistenza come momento di sublime elevazione etico-morale del singolo e della collettività, e il paradigma di Resistenza come prova prettamente conflittuale e ideologico-militare, si strappò il velo al rassicurante repubblicanesimo del paradigma resistenziale sposato dalle forze di governo. Il nuovo paradigma, ruotando attorno al durevole quanto illusorio mito della Resistenza tradita (un mito fondato sull’illusione di un popolo italiano naturalmente rivoluzionario) venne alimentato dal cosiddetto antifascismo militante: la Resistenza come momento eterno («ora e sempre Resistenza») che s’inverava in sintagmi di battaglia quali «presenza militare contro lo squadrismo»; «autodifesa rivoluzionaria delle avanguardie»; «violenza giusta, gappista e di massa». Fu retorica anche questa. E fu opposta a quella della Resistenza tricolore (senza più nemmeno una sfumatura di “rosso”).
Ne usciva, così, ridimensionato lo spazio di narratività di una Resistenza ben più sobria e più aderente alla vita reale, quella di una Resistenza popolare e civile, a cui solo negli anni successivi gli storici cominceranno a dedicarsi, con pagine da cui non emergeva un’oleografia unitaria e perfettamente proporzionata nelle forme e nei modi, quanto un quadro scomposto e irregolare.
Nella Seconda Repubblica, le forze di destra hanno cercato nuova legittimazione all’interno del paradigma resistenziale dominate, cercando di forzarlo a proprio vantaggio, essenzialmente ricorrendo al concetto di buona fede dei vinti. Anche il livello istituzionale ha accreditato il goffo tentativo di trasformare il 25 aprile in una grande occasione di riconciliazione nazionale. Probabilmente la mossa più provocatoria fu quella del ministro Ignazio La Russa che, l’8 settembre 2008, dopo aver fatto l’apologia dei repubblichini, manifestò l’intenzione di scrivere un disegno di legge tendente a mettere sullo stesso piano partigiani e repubblichini, indistinguibili vittime della Seconda guerra mondiale, con il rimarchevole risultato di dover riconoscere ai sullodati secondi tanto diritto alla pensione quanto medaglie al valore.
Nei mesi successivi, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, pur prendendo le difese della Costituzione basata sulla Resistenza, faceva appelli alla riconciliazione in nome dell’unità nazionale. Con tale assist, lo stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, cercò di chiudere la “partita”, con la visita del 25 aprile 2009 a Onna (L’Aquila) in memoria dell’eccidio nazista del 2-11 giugno 1944. Era una novità: in precedenza, il premier aveva snobbato il 25 aprile: nel 2009 no. Circondato dai partigiani dell’Anpi, il premier intrattenne i convenuti con un discorso che riportava, nemmeno tanto a sproposito, qualche frase di Palmiro Togliatti. Ma il punto centrale di quel discorso è il seguente: «La Resistenza è, con il Risorgimento, uno dei valori fondanti della nostra nazione, un ritorno alla tradizione di libertà. E la libertà è un diritto che viene prima delle leggi e dello Stato. Una nazione libera tuttavia non ha bisogno di miti. Come per il Risorgimento, occorre ricordare anche le pagine oscure della guerra civile, anche quelle nelle quali chi combatteva dalla parte giusta ha commesso degli errori, si è assunto delle colpe» [3] . Come dire? Un colpo al cerchio e uno alla botte.
Con la presidenza Mattarella il richiamo all’antifascismo della Costituzione è tornato d’attualità. Ma come stare tranquilli? A che punto stiamo, infatti, con gli ideali costituzionali di giustizia sociale, libertà, democrazia e sovranità popolare se, nel 2015, dopo aver votato una riforma delle Province che cancellava il corpo elettorale, una riforma del mercato del lavoro che livellava i penultimi agli ultimi e in procinto di approvare una legge elettorale che abrogava de facto, se non di diritto, la democrazia parlamentare, i deputati del Partito Democratico, insieme ai partigiani – che erano stati invitati in Parlamento – hanno intonato Bella Ciao? [4]
Non mi sento, tuttavia, come fanno alcuni, di cedere allo sconforto. Non credo che si tratti di prendere congedo dalle speranze e dalle conquiste della civiltà repubblicana [5]. Il 25 aprile è per me una festa dell’unità; l’unità di una parte di popolo che ancora si riconosce nella patria e osa commuoversi quando ascolta l’inno nazionale o il Va pensiero di Verdi. Una parte di popolo che non versa lacrime, però, al ricordo della stessa patria di Cavour, o di quella di Crispi, di Bava Beccaris, Giolitti o Mussolini. Ma per la patria socialista e democratica di Mazzini e di Garibaldi, di Pci e Psi, e di tutte le forze che hanno provato a costruire democraticamente il nostro delicato, fragile e frammentato Paese.
Perché la patria che si celebra il 25 aprile è certamente un concetto, una costruzione immaginaria. Ma, come sostiene Benedict Anderson, una comunità immaginata non è meno vera, meno reale, meno sentita e meno vissuta di quella reale. Che cos’è una «comunità reale»? Anderson scrive: «Le comunità devono essere distinte non dalla loro falsità/genuinità, ma dallo stile in cui esse sono immaginate. La nazione è immaginata come “limitata” in quanto persino la più grande, con anche un miliardo di abitanti, ha comunque confini, finiti anche se elastici, oltre i quali si estendono altre nazioni. Nessuna nazione s’immagina confinante con l’umanità» [6]. Probabilmente oggi gran parte degli Italiani non si riconosce nel concetto di patria di Mazzini o di Garibaldi. E questo per tante e motivate ragioni.
Credo, però, che, al di là del ragionamento storiografico, a ognuno di noi tocchi chiedersi, anche e soprattutto in quanto intellettuale, se davvero basti la competenza specialistica nell’approccio e nello studio dei riti nazionali e non occorra invece assumere toto corde la responsabilità derivante dalla dimensione pubblica del proprio agire discorsivamente nella polis. Perché, come ha sostenuto Edward W. Said in Dire la verità (1994), non esiste mai un’indipendenza assoluta dall’influenza che il nostro ambiente esercita su di noi. Non esiste via di fuga dal contesto di lingua, immaginazione sociale, educazione, in cui siamo nati e ci troviamo gettati. Le passioni collettive sono intrascendibili. Persino quando parliamo il linguaggio dell’universalismo, quel linguaggio è già interno a un patrimonio che ereditiamo con la nascita e la maturazione in una data comunità. La patria o la nazione, e la loro lingua, il loro discorso, non sono entità sospese in aria, in attesa di essere maneggiate da qualcuno in più o meno aperta malafede: bisogna semplicemente cercare di appropriarsene per poterle usare, il più possibile a fin di bene. Per il bene della patria. Di ogni patria. Per tutto questo, una riflessione sul 25 aprile non può esaurirsi in una discettazione storiografica.
Said è molto chiaro: contro l’attività intellettuale come professione qualsiasi, conforme alle altre attività umane, bisogna opporre il dilettantismo, inteso come «desiderio di agire non sulla spinta di un guadagno o di un riconoscimento ma per amore di un disegno di più vasto respiro» [7]. Un’attività che «trova il suo alimento nella responsabilità e nella passione anziché nel profitto e nell’egoistica, angusta specializzazione» [8].
Mai anteporre la solidarietà nazionale o la fedeltà al rito rispetto alla necessità della critica, è ovvio. Ma una critica che non sappia fare un po’ di spazio per comprendere come il popolo costruisca i propri miti o li accetti quando sono costruiti da altri (anche se poi li modifica internamente) è una critica raziocinante e fredda che dà luogo alla passività, induce all’inerzia e alla pigrizia, al ritiro nella propria dimensione privata, di studio e di riflessione. La forza di ogni imperialismo si fonda principalmente sulla disponibilità a servire il potere di popoli e intellettuali. Un assoggettamento spesso ammantato con motivazioni apparentemente nobili o frutto di meschini calcoli opportunistici.
Sono gli imperi a costruire racconti universali e onnicomprensivi, anche ricorrendo a nobili padri fondatori o illuminati pensatori. Come sostiene il filosofo conservatore Yoram Hazony, «ogni teoria imperiale con cui si abbia familiarità – che sia egizia o assira, greca o romana, cristiana o islamica, liberale o marxista – sempre propugnò un’ideologia di salvezza e pace universali. Persino l’imperialismo nazista coincise con un credo salvifico, che elargiva al mondo promesse di pace. Non appena una siffatta ideologia imperialista ebbe a collidere con un preciso rifiuto della salvezza che si prefiggeva di arrecare, essa rispose con profondo e radicato odio. Sembrerebbe, infatti, che l’universale possa amare tutti gli esseri umani e tutte le nazioni, fintantoché siano disposti a farsi determinare nel pensiero e nell’azione da questo universale» [9].
Spesso ci facciamo ingannare dalla critica ai mali del nazionalismo (che pure ci sono stati e ci saranno). A ben guardare, esiste un nazionalismo difensivo che, nella storia, ha dato origine a fenomeni virtuosi, come la decolonizzazione. Il che non implica che, nell’acquistare l’indipendenza, gli ex colonizzati non abbiano percorso, a volte, le stesse strade violente e disumane intraprese dai colonialisti europei. Il mito della patria repubblicana, come peraltro il mito della nazione democratica, rientra in quei dispositivi narrativi che i popoli costruiscono o a cui credono perché è nell’economia vitale della loro esistenza costruirli o crederli come veri. Come scrisse il poeta Aimé Césaire, uno dei più autorevoli esponenti delle lotte di liberazione dei neri d’Africa, nonché coautore della nozione di négritude, per costruire una nazione occorre inventare nuove anime.
Quando lo storico pensa la patria italiana, la pensa in modo scettico e raziocinante, in modalità “scientifica”. E invece dovremmo provare a pensarla dal punto di vista della disposizione soggettiva di chi ha preso parte al Risorgimento e alla Resistenza. Ciò non significa non decostruirne il mito al fine di poterne criticare le modalità di realizzazione e gli esiti politici che ha prodotto – soprattutto quando essi confliggano con i valori in cui si crede (pensiamo al concetto di patria fascista). Per pensare alla nostra storia nazionale, dovremmo fare come hanno fatto due celebri patrioti anticolonialisti, il poeta nazionalista indiano Rabindranath Tagore e il rivoluzionario cubano José Martì: essere patrioti senza mai smettere di criticare la patria. È questo il vero senso del repubblicanesimo classico e il punto di forza di un grande pensatore della politica moderna, Niccolò Machiavelli, che, nei Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio, arrivò a contemplare anche il conflitto come elemento basilare della “costituzione materiale repubblicana”.
Questa operazione non è impossibile né si tratta di qualcosa di ormai tramontato e inservibile nel presente: la trascendenza a disposizione dell’intellettuale laico consiste proprio nel sapersi muovere dal piano orizzontale della sua contingenza (la sua presenza in un dato tratto spazio-temporale della vicenda storica generale) al piano verticale dei diritti di una più vasta umanità: come raccomandava Frantz Fanon nei Dannati della terra, non bisogna mai smettere di segnalare il legame esistente tra gli orrori compiuti a casa propria con «i tormenti subiti da altri».
In conclusione, il 25 aprile è per me, ancor oggi, e nonostante tutto, festa della patria liberata, festa della libertà e della inclinazione fraterna verso l’altro. È la festa di tutti coloro che combattono la blandizie del successo, della fama, della gloria personale; contro le dittature; contro il consumismo di massa dell’Occidente. Il 25 aprile è per me la festa di ogni patria, di ogni uomo e ogni donna, che trova nella partecipazione appassionata, nell’impegno per una patria e un mondo più libero e più giusto, il senso del proprio esserci.
[1] Gianpasquale Santomassimo, 25 aprile. Liberazione dal fascismo, in Calendario civile. Per una memoria laica, popolare e democratica degli italiani, a cura di Alessandro Portelli, Donzelli, Roma 2017.
[2] Sui caratteri certamente non moderati e difficilmente sussumibili all’interno del discorso politico liberaldemocratico è particolarmente incisivo l’encomiabile lavoro critico di Giovanni Belardelli. Anche se il verbo mazziniano aveva in odio più l’egoismo che la borghesia, fu un fatto che gli Italiani del ceto medio del suo tempo considerassero il Genovese come un agitatore irresponsabile che sfruttava gli odi di classe; secondo Carlo Cattaneo, la piattaforma di Mazzini, a causa della sua insistenza su unità e coesione sociale, aveva indubitabilmente una caratterizzazione «dittatoria, cesarea, napoleonica» G. Belardelli, Mazzini, il Mulino, Bologna 2010, p. 160. Aggiunge, infine, l’autore: «È appena il caso di osservare che sia la contrarietà ai partiti, concepiti come elementi di divisione di una volontà generale che è e deve restare una e indivisibile, sia l’avversione alla divisione dei poteri mostrano come Mazzini si muovesse nel solco della tradizione democratica rousseauiano-giacobina, non diversamente del resto dal repubblicanesimo d’Oltralpe»; ivi, p. 152.
[3] https://www.corriere.it/politica/09_aprile_25/discorso-berlusconi-25-aprile-onna_00e34c08-31b6-11de-98f0-00144f02aabc.shtml
[4] https://www.orticalab.it/Stracciano-la-Costituzione-e
[5] Gianpasquale Santomassimo, 25 aprile, cit.
[6] Benedict Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Laterza, Bari-Roma 2018, p. 11
[7] Edward W. Said, Dire la verità. Gli intellettuali e il potere, Feltrinelli, Milano 2014 (I ed. 1994), p. 85
[8] E.W. Said, Dire la verità, cit., p. 95.
[9] Yoram Hazony, Le virtù del nazionalismo, Guerini e associati, Milano 2019, p. 308.